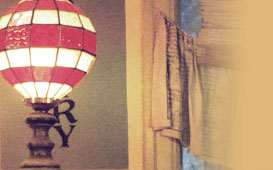|
|
13/11/2025
Mustafa ci fa riconoscere il viale dei cecchini che abbiamo percorso qualche ora prima e poi fa un gesto con la mano, ne cambia l’inclinazione rendendo più acuto l’angolo che unisce il suo corpo a quello della città che sta lì sotto. Guardate, dice: secondo voi quanto è distante? Non dice a cosa si sta riferendo, ma gli occhi e il dito puntano verso il ponte e Terezje, uno dei viali che costeggia la riva sinistra del fiume. Andrew fa subito un gesto con le spalle come per dire amico, sono qui perché me lo dica tu; io ci provo ma butto un numero a caso come quando una signora del British Museum mi mise in mano un pezzo di selce che mi aveva spiegato essere un utensile da cucina preistorico e mi chiese secondo me quanto poteva essere antico (dissi sei-settemila, lei rise bonaria e mi informò che sarebbe stato meglio se avessi stretto un po’ di più la presa, perché quel sasso aveva quattrocentomila anni di età), tento quasi più per far piacere a Mustafa che per cercare di dare una risposta giusta perché con le misurazioni a occhio non sono mai stato un granché, non so stimare una distanza, un’altezza, un peso. Non credo che Mustafa mi ascolti, e d’altra parte come dargli torto: tiene lo sguardo verso la città e dice, come se parlasse a se stesso: “mille, mille e cento”. Lo guardo perché d’acchito non capisco di cosa parla. “Da qui al fiume sono mille metri, mille e cento al massimo”, continua, e spiega che era la gittata massima dei fucili di precisione usati dai cecchini serbi, oltre la quale anche soggetti molto ben addestrati come quelli non potevano garantire l’accuratezza del tiro. Ma mille, mille e cento metri era la distanza giusta, potevano colpire chi volevano, in qualunque momento. Quindi stavano qui, avevano qui una postazione? gli chiediamo e lui con l’altra mano indica un punto indistinto che sta più o meno alle nostre spalle, a qualche metro di altezza sopra le nostre teste. Non posso parlare per Andrew ma io riesco solo a vedere una macchia di cespugli e nulla che faccia immaginare una possibile disposizione di uomini e armi. “Quel sasso”, dice Mustafa, “quello bianco che vedete lì”, circa a metà del cespuglio, lo dice con la stessa ostinata urgenza che ha usato quando si è incaponito a farci individuare il palazzo vicino all’aeroporto nel quale viveva con i genitori e il fratello quando iniziò l’assedio; e quando capiamo di cosa sta parlando, a cosa si sta riferendo non possiamo evitare di mostrargli il nostro perplesso stupore perché quello che ci sta mostrando è uno spuntone calcareo che sarà largo un metro e lungo forse due, una cosa che esce dal profilo della collina come un naso coperto di rami e foglie e ci rifiutiamo di credere che un uomo potesse passare abbarbicato lì sopra anche solo dieci minuti, figuriamoci le ore di immobilità che fanno parte integrante del lavoro di un cecchino in tempo di guerra. E invece Mustafa ci conferma che chi era di turno stava proprio lì, che la posizione era scomoda ma perfetta per copertura e visuale.
Riporta lo sguardo verso il basso, verso la città e il fiume che la attraversa: “erano bravi i serbi”, dice, e mi pare di sentire nella sua voce l’inevitabile e insopprimibile e paradossale ammirazione che una persona buona e onesta prova nei confronti di chi fa bene il suo lavoro anche se questo consiste nello sparare a un innocente che sta andando a comprare il pane. E’ un riconoscimento che viene da lontanissimo, dai nostri avi, dalla scuola, da un modo di stare al mondo che per arrivare a definire l’orrore deve fare una mezza dozzina di passi di razionalizzazione, prima dei quali sta la spontanea ammirazione per la combinazione di capacità e applicazione che rende alcuni soggetti speciali e li fa spiccare nel loro perimetro di competenza, sia questo il campo di calcio per Messi o la creazione e gestione del sistema di trasporto verso i campi di sterminio per Eichmann. Erano estremamente ben addestrati, dice Mustafa guardando verso il fiume, non sbagliavano mai. Ferivano se volevano ferire, uccidevano se volevano uccidere. Tu conoscevi la loro posizione, quello che non sapevi e non potevi sapere era quando avrebbero deciso di sparare, quando ne avrebbero avuto voglia o ricevuto l’ordine. Fissiamo la Miljacka e il ponte e quel pezzetto di Sniper Alley che si può vedere dallo spiazzo nel quale Mustafa ci ha raccontato la storia di un cecchino e delle sue vittime con un’assenza di enfasi così evidente da renderla addirittura tangibile e per un momento, che non ho idea di quanto sia durato, restiamo in silenzio, lui a ricordare e noi a immaginare sapendo di non poterci riuscire, non davvero. Con un mezzo sorriso Mustafa ci dice che è ora di andare, di tornare a Sarajevo e noi ci avviamo verso la macchina, buttando un ultimo sguardo verso lo spuntone di pietra sul quale si sdraiava il cecchino, che chissà se gli veniva mai mal di schiena, se gli capitava di tremare per il freddo e sudare per il caldo, se provava piacere a sparare, se si pisciava addosso a tre quarti di un turno, che chissà chi era e che faccia aveva.
A me non fa né caldo né freddo sapere che ci sono stati cento, duecento, mille italiani che hanno pagato per andare a tirare sui sarajevesi che cercavano di sopravvivere un altro giorno: se se ne vuole fare una questione contabile allora si deve ricordare che ce ne sono stati migliaia – decine, centinaia di migliaia – che per la Bosnia hanno fatto tutto il bene possibile, e continuano a farlo oggi. Il punto non è quello, non può e non deve essere quello, il punto è chi, cosa sei se ti va di aprire il portafogli per provare ad ammazzare uno sconosciuto inerme che sta a mille, mille e cento metri di distanza.
03/11/2025
Ho scritto e mi hanno pubblicato un libro che parla di come una guerra continua a produrre effetti sulla vita delle persone comuni a trent’anni dalla sua fine ufficiale. Sono stato cinque volte in Ucraina al seguito di missioni umanitarie e conto (temo) che ce ne sarà almeno una sesta, e quel paese sta dentro la mia vita non solo per motivi politici o sociali o legati a grandi principi ma perché ci vivono persone amiche. Come tanti, ho fatto quel che mi era possibile – soldi, partecipazione, informazione – per Gaza, sentendo l’anima stringersi a ogni immagine che da lì arrivava.
L’altroieri ho parlato con un’amica con la quale abbiamo condiviso giorni di accoglienza al termine della rotta balcanica e poco fa ho letto le ultime dal Darfur e, semplicemente, mi sono sgonfiato. Deflated, come scrive Elizabeth Strout descrivendo l’anima di Lucy Barton che – letteralmente – si sgonfia dopo che un uomo con il quale ha una relazione ha detto due parole sventate e perciò profondamente vere. Deflated come quando ti guardi dentro e non trovi più una stilla di energia, perché tutto ti sembra troppo, perché non puoi avere cuore e tempo e risorse per tutte le brutture per le quali vorresti fare qualcosa. Deflated, e non so cosa farci.
29/08/2025
[Un libro non si nega a nessuno] E insomma, ci siamo.
Ho cominciato ad andare da quelle – queste? – parti, intendo la ex Jugoslavia, poco meno di vent’anni fa.
Prima non ci ero mai stato, non ci ero andato in vacanza quando avevo vent’anni. Poi c’è stata una prima volta, per caso, per motivi di lavoro, e poi una seconda, ancora per caso, ancora per motivi di lavoro: in quel periodo ci ho passato un bel po’ di tempo, andavo almeno due volte al mese a Ljubljana, e poi Zagabria e Belgrado e diversi altri posti. Mi sono incuriosito, ho parlato con persone, ho visitato dei luoghi. Mi è venuta voglia di saperne di più, alla fine è diventata una specie di ossessione (se non ci credete potete chiedere a mia moglie che quando siamo andati in vacanza in Croazia e Bosnia si è dovuta sorbire ore di racconti, “qui è successo questo, dietro quella montagna è successo quell’altro”: però, siccome ho un cuore e le voglio bene un primo giro dei luoghi dei massacri me lo ero già fatto, da solo). Sempre per caso il lavoro mi ha portato ancora da quelle parti una terza volta, a girare per Albania, Kosovo e Macedonia. Quando potevo mi ritagliavo del tempo e andavo a vedere con i miei occhi: non so, la collinetta di Kosovo Polje dove Slobodan Milosevic nel 1989 fa partire l’incendio con un discorso che chiama a raccolta i serbi, Mitrovica dove si vive ancora come a Berlino ai tempi della guerra fredda, solo che al posto del muro c’è un ponte che è presidiato anche dai nostri carabinieri, cose così (ah, una cosa che si impara, almeno io credo di averla imparata, è che il caso, se si ripete, non è più tale anche se lo sembra; ma questo è un altro discorso).
Dopo tanti anni mi sono messo a scrivere qualche pezzo, che è stato pubblicato da una rivista online che si occupa di Balcani e Est Europa: si chiama Meridiano 13, se non la conoscete dovreste dedicarle un po’ di tempo; dite pure che vi mando io, e che gli sono molto grato. Dopo un po’ mi è sembrato che ci fosse qualcosa che li teneva insieme, quei pezzi: non ne sono sicuro al 100% ma credo che fosse la sensazione, vorrei dire la certezza che le guerre raramente finiscono quando si smette di combattere, perché vanno avanti in una forma diversa che qualcuno si azzarda a chiamare pace e così diventano una parte integrante della vita delle persone comuni, quelle che al mattino si alzano, fanno colazione, vanno a lavorare o a cercarsi un lavoro, tengono insieme la famiglia. E al tempo stesso un’altra certezza, e cioè che la guerra è un fantasma che alimenta sia le mie ossessioni di adulto che ha girato il mondo che quelle di tanta stampa, di tanta politica e forse anche di certa cooperazione che per cecità o interesse sembrano rimaste agli anni Novanta.
Nel frattempo era iniziata la guerra in Ucraina. Un’altra guerra che ci toccava da vicino anche se combattuta a duemila chilometri dalle nostre case; chi passa da queste parti sa che mi ci sono dedicato e continuo a farlo – le missioni umanitarie, l’informazione, il sentire gli amici una volta alla settimana per sapere come vanno le cose, come stanno i ragazzi, se è arrivato l’inverno e c’è abbastanza riscaldamento. A quel punto mi è sembrato che le vicende della Bosnia, della Croazia, del Kosovo non fossero più un reperto storico ma qualcosa di vivo da rimettersi sotto gli occhi per capire cosa stava succedendo e soprattutto cosa potrebbe succedere quando anche lì si smetterà di usare le armi, cosa significherà nella vita delle persone comuni, gli ucraini di Leopoli e Kharkiv e Chernivtsi, una pace giusta e quindi vera oppure una pace che sarà solo una tregua. Ho scritto qualche altro pezzo, ho messo tutto insieme e niente, qualcuno ha creduto che potesse venirne fuori un libro con una sua dignità. Questo qualcuno si chiama Infinito Edizioni e naturalmente sono loro più che grato, anche se ogni tanto ci penso e mi viene in mente quella frase fulminante che Tucidide mette in bocca agli ambasciatori ateniesi che si rivolgono ai loro omologi di Melo: “mentre ci rallegriamo per la vostra ingenuità, non vi invidiamo la follia”.
Insomma, oggi esce “Lungo il fronte – viaggio accidentato nella Jugoslavia scomparsa”. Una cosa curiosa che sta dietro la sua stesura è che è avvenuta spesso in luoghi bizzarri: un ponte dal quale si dice che sgorgano lacrime, una Schnellbahn svizzera, l’ingresso di un circolo di conversazione nella Sicilia barocca, il bordo di una fossa comune. Della sua qualità non posso giudicare, ovviamente: credo che possa interessare non solo chi ama il genere del reportage ma anche e forse soprattutto chi si fa domande sui tempi di guerra che viviamo. Non che ci siano le risposte, ma magari qualche bagliore che a libro chiuso faccia dire “ah ecco, vedi” forse c’è.
Ovviamente tengo molto a questo libro, come si fa con tutto ciò nel quale ci si mette del proprio. E quindi gli auguro un paio di cose: di essere venduto (lo trovate qui https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/lungo-il-fronte/, qui https://amzn.eu/d/aIL0TlY, nei vari altri store online e spero nella vostra libreria del cuore se ne avete una); e, così come a chi lo leggerà, di fare e far fare degli incontri belli, o memorabili, come quelli che lo riempiono: e se qualcuno, dopo averlo letto, un incontro vero e proprio lo volesse organizzare beh, parliamone.
22/07/2025
Era la fine dell’estate del 1987. Io stavo a metà dei miei presunti quattro anni di Bocconi ma ero ancora il tizio di periferia che aveva impiegato parecchio tempo ad abituarsi a quei suoi coetanei che si erano presentati al primo giorno di università in giacca blu, pantaloni grigi con la piega e ventiquattrore rigida. Uscì l’edizione europea di Time – era ancora un’epoca di carta – che sotto la testata portava un titolo semplicissimo: “Milano!”. Stava tutto in quel punto esclamativo, la foto della volta di Galleria Vittorio Emanuele e quella della sala contrattazioni della Borsa erano solo il contorno. Dentro quel punto esclamativo c’era la Milano che aveva un nome nel mondo, la Milano che cresceva e correva e risplendeva, la Milano da bere e quella da indossare. Non era la mia per il semplice motivo che io ero figlio di un’altra città, quella che stava oltre la circonvallazione, fatta di periferie chiamate dormitori, redditi sotto la media, sveglie all’alba e autobus che attraversavano confini invisibili ma non meno percepibili.
Non era la mia, quella città, e avrei potuto guardarla con l’astio del figlio illegittimo che non godrà mai dell’eredità familiare. Invece presi la rivista (credo che fossi abbonato, gli studenti godevano di condizioni di grande favore), la misi dentro una cornice molto semplice e l’attaccai al muro della mia camera. Non era la mia, quella città: e al tempo stesso lo era, più di quanto mi fossi mai reso conto, ed ero orgoglioso di lei, del suo splendore, della sua ricchezza in crescita, del suo saper stare sotto i riflettori facendosi invidiare dal resto del mondo. Poi sono cresciuto e maturato; pochi anni dopo preparando la tesi avrei toccato con mano l’implosione di una classe politica che riempiva il Palazzo delle Stelline vendendo garofani rossi a cinquemila lire e non spolverava più le scrivanie degli uffici affittati vicino alla Cattolica, pagai lo scotto di laurearmi non un minuto prima ma un minuto dopo l’inizio della crisi economica del 1991 e le cose andarono come vanno sempre per quasi tutti, a cicli, a salite e discese. Quella copertina rimase appesa al muro per molti anni e non escludo che lo sia ancora, nascosta in bella vista sotto gli occhi in una casa nella quale continuo a entrare tutti i giorni: rimase lì perché non avevo nessun motivo di toglierla o di chiedere ai miei di farlo, perché di quella città mi sentivo più parte di quanto non avvenisse quando avevo sedici o diciannove anni.
In questi giorni ho pensato spesso a quella copertina, a quel punto esclamativo, a come mi sentivo io guardandolo. E’ dal 2015 che siamo tornati a metterlo subito dopo il nome della nostra città e lo abbiamo fatto per molto tempo con quello strano orgoglio che ci porta a dire “noi” come si fa con le squadre di calcio – l’hai vinta forse tu la Champions? certo che no; eppure; vogliamo aggiungere il beneficio della sensazione di sentirsi più ricchi perché il valore del mattone acquistato a costi ancora praticabili cresceva di anno in anno e poi ti poteva pure capitare di diventare un proprietario vero, di quelli che può rivendere e ricomprare senza dover accendere un altro mutuo e anzi magari chiudendo il proprio perché ti cascava in mano il tre locali dei genitori arrivati ormai alla fine dei loro anni. Dentro quel luccicore ci siamo stati dentro in tanti, e a lungo con piacere e compiacimento: abbiamo visto che il meccanismo si stava ingrippando, ma non per noi, non per la maggioranza di noi che eravamo entrati nel perimetro della circonvallazione pur continuando a vivere a Molino Dorino o a Lorenteggio. Questo spiega tutto ciò di cui si sta parlando, spesso male, in questi giorni? No, certo, ci mancherebbe altro. Ma va tenuto in conto perché, come scriveva Musil, “non si può fare il broncio ai propri tempi senza riportarne danno”.
19/07/2025
Faccio una premessa: il report di Albanese, quanto meno nella sua traduzione italiana, parte certamente da un bias personale. Da che parte sta FA lo si capisce subito, basta la prima mezza pagina. Sempre facendo la tara della traduzione (immagino che il documento sia stato scritto in inglese, dubito comunque che la stesura sia avvenuta in italiano), la lingua ricorda un certo sessantottismo terzomondista al quale si devono riconoscere tanti demeriti quanti meriti e buone intenzioni: a FA il capitalismo non piace, questo è poco ma è sicuro. Non le piace nemmeno Israele, o almeno il modo in cui è nato (c’è una brutta espressione di cui colpevolmente non ho fatto copia e ora non ho voglia di cercare, ma che sostanzialmente riduce la sua creazione a un atto di occupazione violenta delle terre dove vivano i palestinesi: che è una cosa vera e falsa al tempo stesso).
Detto questo, ho fatto uno sforzo e il report me lo sono letto. Ed è un report che parla di una cosa ben precisa: della responsabilità delle aziende nell’esercitare la propria attività quando questa entra in contatto con un teatro di guerra. Questo e non altro, e francamente fatico a pensare che chi sostiene una cosa diversa non sia in malafede, perché la sola opzione alternativa sarebbe la stupidità innestata sull’analfabetismo. Purtroppo FA commette un grave errore nella definizione della struttura del documento e questa cosa la fa capire bene solo a pagina 20, punto 2.2 “Responsabilità delle imprese”. Il punto di partenza sono gli UNGP (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. These principles, adopted by the UN Human Rights Council in 2011, provide a global standard for preventing and addressing human rights harms related to business activities). Potete approfondire a vostro piacimento, ma in sostanza: “Gli UNGP si applicano a tutte le imprese, “indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore, dal contesto operativo, dalla proprietà e dalla struttura”, La responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani e i crimini di diritto internazionale esiste indipendentemente da quella degli Stati e a prescindere dalle azioni che gli Stati intraprendono o meno per garantire il rispetto dei diritti umani. Di conseguenza, le imprese devono rispettare i diritti umani anche se lo Stato in cui operano non lo fa, e possono essere ritenute responsabili anche se hanno rispettato le leggi nazionali in cui operano. In altre parole, il rispetto delle leggi nazionali non preclude e non costituisce un’eccezione alla responsabilità.”
Due terzi del documento sono un elenco di aziende e organizzazioni che vengono meno a questo impegno, a questa cosa che – volendo essere forse un po’ naive – dovrebbe essere un obbligo morale alla base dell’attività aziendale. Vi dirò una cosa: so di cosa si parla: non più tardi della settimana scorsa ho firmato un contratto con una charity internazionale nel quale impegnavo l’azienda per la quale lavoro a non fornire informazioni (indirizzi e numeri di telefono, niente meno) che mettessero l’organizzazione in condizioni di ricevere donazioni da aziende che lavorano in un numero piuttosto elevato di settori merceologici: non starò a tediarvi, ma per ciascuno di quella quarantina di codici ATECO che non posso considerare, rinunciando così a fatturato, c’è un perché. A volte bisogna fare non uno ma due o tre passi a ritroso per trovarlo, ma c’è.
E insomma, il punto è quello: fare soldi in modo diretto o indiretto con l’occupazione di territori che avviene in violazione delle richieste della corte penale internazionale e di qualche decina di altre raccomandazioni di istituzioni internazionali a partire dalla stessa ONU. A proposito, magari non lo sapete (io non lo sapevo) ma è dal 2016 che le Nazioni Unite, attraverso OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, hanno creato un database di questo tipo, che raccoglie i dati di chi degli UNGP si disinteressa bellamente ed è un database purtroppo – ma non sorprendentemente – bello grosso. C’è tanta gente che quei soldi li fa, li facciamo anche noi con Leonardo che è un’impresa statale e quindi anche nostra, di cittadini italiani.
Finisco: io, dal basso del mio essere un signor nessuno, al posto di FA non avrei usato il termine genocidio per motivi che avrebbero bisogno di più spazio per essere spiegati*; ma incistarsi su quello lasciando perdere tutto il resto, cioè le dieci pagine di vero contenuto di quel documento, beh: luna, dito, cecità, incapacità di cogliere il contesto, magari disonestà. Cose così.
*Ci provo lo stesso: davvero, il punto non è se questo è genocidio o meno. Quella è una faccenda da tribunale e non è che se ci si macchia di crimini di guerra o di crimini contro l’umanità la faccenda cambia più di tanto. Per me il punto, fin dall’inizio, è un altro. E’ che se tu sei uno stato democratico (cosa della quale io non dubito, per intenderci) e hai di fronte un’organizzazione terroristica e ti ritieni ed affermi di essere migliore di quel tuo nemico beh, devi essere migliore. Lo devi essere in tutti i sensi, prima di tutto quello morale, etico, chiamiamolo come vogliamo. Anche a costo di soffrire più di quel che dovresti, perché avere ragione non significa essere nella ragione: ti devi comportare di conseguenza; i limiti li puoi stiracchiare ma non li puoi eliminare del tutto, vantandotene persino. E, da fuori, da soggetti non direttamente coinvolti, non si può stare dalla parte di chi approfitta della ragione per poter fare il male senza subirne conseguenze.
11/07/2025
[Oggi, trent’anni fa, iniziavano i cinque giorni del genocidio di Srebrenica]
C’è un luogo dove torno e mi fermo, prima di entrare nella cittadina che fu il vero centro operativo del genocidio. Potočari, con la fabbrica che fungeva da quartier generale dei caschi blu e i suoi spazi enormi e umidi che diventarono troppo piccoli per contenere le migliaia e migliaia di persone terrorizzate in fuga dalle truppe di Ratko Mladić, la distesa di stele bianche a coprire le colline come uno scialle di marmo, il piccolo chiosco che, con una certa dignitosa sobrietà, vende le spille con il fiore fatto di undici petali bianchi intorno al centro verde come il paradiso islamico e come le bare delle vittime, la fossa comune secondaria di Budak 1 di cui mi sono salvato le coordinate geografiche – un rettangolo di terra sulla quale pare che l’erba faccia fatica a crescere mentre tutto intorno vi è un rigoglio esemplare di piante da frutto. Mi resta l’immagine di una donna velata che prega piangendo le lacrime di un dolore inesauribile, inginocchiata di fronte a due tombe. Il compagno la aspetta a qualche metro di distanza, custodendone la solitudine come se non volesse rompere con la propria presenza il cerchio intimo che lega la donna alle due colonne di marmo sulle quali, insieme ai nomi dei due morti, è inciso il meraviglioso versetto del Corano che recita: “E non dire di quelli che sono morti sulla via di Allah: ‘Sono morti’. No, sono vivi ma tu non li senti”. Li fisso restando in disparte, provando l’irrazionale istinto di andare da quella donna e abbracciarla come se questo potesse servire, o avere un senso; quando si alza, l’uomo le si avvicina e le si accosta accompagnandola lungo il breve sentiero sterrato che divide un campo di tombe da un altro in direzione del grande ingresso del cimitero: io, invece, mi porto lentamente di fronte alle due tombe, ne leggo i nomi e l’identico cognome – immagino due fratelli, uno di diciannove e l’altro di ventitré anni nel giorno in cui vennero massacrati, e una sorella che è morta quel giorno restando poi incollata al destino implacabile e spietato di chi rimane, sentendosi in colpa per il solo fatto di essere viva. Uscendo dal cimitero mi torna in mente il luminoso giorno di dicembre in cui mi trovai insieme a un collega ad aspettare l’autobus che collega il campo di Auschwitz a quello di Birkenau. Scambiammo le quattro parole senza peso che si dicono per non restare completamente in silenzio quando si è in compagnia, anche se quella sarebbe l’unica cosa sensata e giusta da fare: tacere, deglutire e tenere dentro a forza quel che si è visto sapendo che si sta per incontrare qualcosa di ancora peggiore. Ci avvicinammo a Michele, la guida che ci accompagnava nella visita dei campi, l’uomo che un secondo prima di muovere il passo verso il cancello del campo, quello dell’Arbeit Macht Frei, ci aveva detto serio e quasi tagliente: “Questa non è una gita, non è un’escursione; state entrando in un cimitero, comportatevi di conseguenza”. Gli chiedemmo da quanto tempo faceva quel mestiere, portare per tre ore abbondanti piccoli gruppi di persone a guardare con i propri occhi i luoghi del più grande sterminio organizzato che la storia ricordi. “Otto anni”, rispose, e a noi sembrò un’enormità, otto anni di crematori e camere di tortura, torrette e baracche, mucchi giganteschi di scarpe e capelli, valigie, uniformi a strisce e latrine. “Com’è questo lavoro?” gli domandammo, senza riuscire né ad articolare meglio né tanto meno a immaginare la risposta; lui fece un sorriso mesto e consapevole: “Non è il dentro, sono le domande che ti fai quando sei fuori”, disse con una voce tranquilla, e dentro si sentiva qualcosa che non era stanchezza o rassegnazione, quanto piuttosto la convinzione ostinata, costruita giorno dopo giorno e crematorio dopo crematorio, che devi provare a dare un senso a quello che fai per renderlo utile, buono e giusto per te e per gli altri. Poi arrivò l’autobus, Michele ci fece cenno di salire e noi ci muovemmo. Faceva freddo ma era una bella giornata di sole, come oggi a Potočari.
13/06/2025
Ogni tanto, e sempre più spesso, leggo in giro frasi “un giorno ti chiederanno dov’eri quando a Gaza (Kharkiv, o un altro luogo di massacri a scelta) i bambini morivano, e cosa facevi”. E io, che da quando ho letto “Come si diventa nazisti” di William Sheridan Allen non sono più lo stesso – nessuno dovrebbe esserlo dopo essere passato da quelle pagine fondamentali, nessuno dovrebbe perderle – penso a dove sono, cosa sto facendo, cosa non sto facendo; ci penso tutti i giorni e no, non è un modo di dire: e sono abbastanza sicuro che il problema più grande non è cosa sto o non sto facendo oggi ma è quello che ho o non ho fatto ieri e l’altroieri perché i buoi sono già scappati e sono tanti e corrono veloci.
21/03/2025
Eravamo all’inizio della pandemia. Una videoconferenza con un ex collega. Roba di lavoro, ma ci potevamo permettere un po’ di sbrago, quello della confidenza di gente che ha passato tante ore alla stessa scrivania e per un caso della vita è diventata amica. Davanti allo schermo si presentò suo figlio, tre anni compiuti non da molto. Il piccolino mi fece ciao con la mano, mi chiese come si chiamava la mia bambina, cose così. Gli chiesi “E tu come stai? Ti annoi?”: “No, io aspetto di crescere”. Adesso scrivo al papà e mi faccio aggiornare.
23/02/2025
Non so se lo è anche in ordine cronologico, so che il primo ricordo che ho della mi’ mamma è di me piccolo – credo cinque anni, prima di andare alle elementari – seduto da qualche parte, probabilmente sul pavimento, che sfoglio qualcosa, probabilmente un fumetto, direi Topolino. Lei sta poco dietro la mia spalla destra, probabilmente inginocchiata, seguendomi mentre io passo il dito sulle figure e le parole scritte all’interno delle nuvolette sopra le teste dei personaggi: non la vedo ma so che è lì, al mio fianco; come fanno le mamme, come ha fatto lei per tutta la vita, ancora oggi. Ho imparato a leggere con mia mamma, no, la verità è che lei mi ha insegnato a leggere a dispetto della sua quinta elementare con l’amore che ha avuto fin da piccola per quegli oggetti nei quali gli umani hanno spesso distillato il meglio di quel che hanno dentro e che lei per tanto tempo ha solo potuto desiderare, lei che porta i due nomi della Madonna della Neve e a Milano usano il secondo e chiunque altro la conosca la chiama con il primo. Oggi arriva a ottantotto, ogni tanto parliamo di questo o quel libro, lei mi chiede di metterle qualcosa di nuovo sul Kindle, io penso che leggere è una delle tre o quattro cose più importanti della mia vita e infatti cerco di farlo in qualunque momento e situazione e non sono capace di addormentarmi senza le ultime due o tre o venti pagine della giornata e mi rendo conto di quale pazzesco regalo mi ha fatto, senza saperlo ma, sono certo, con tutta la forza che aveva, quella inscalfibile dei nuraghi dai quali viene.
14/02/2025
Non ho mai avvertito particolari imbarazzi nello scrivere cose destinate ad altri; figuriamoci, sono uno di quelli che con scarso senso del ridicolo si è persino autopubblicato due libri. Eppure, in questi ultimi anni quando ho pensato di scrivere qui, un posto che ho aperto esattamente ventidue anni fa, ho provato sempre più frequentemente una sensazione di imbarazzo. Non inutilità, proprio imbarazzo: quello che si prova per motivi di forma, opportunità, buona creanza. Non saprei dire il motivo, probabilmente – come accade quasi sempre – non ce n’è uno solo. Ma è così, ed è come una specie di disagio senile: mi piacerebbe non provarlo, non così intenso, perché penso che tanti piccoli spazi come questo, come i blog di venti anni fa sarebbero ancora utili dentro una cornice più grande. E però.
|
|
|